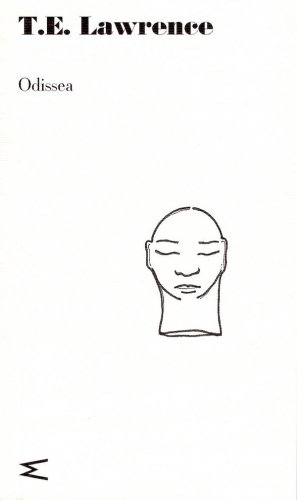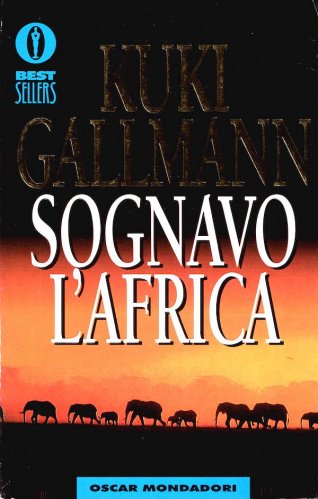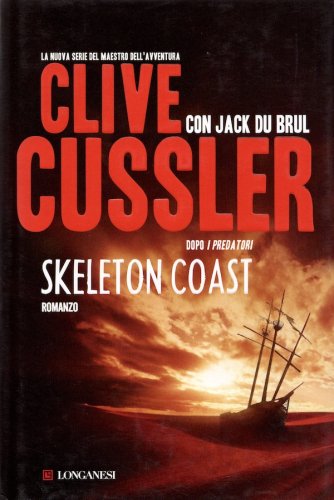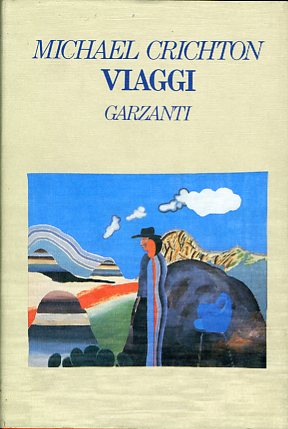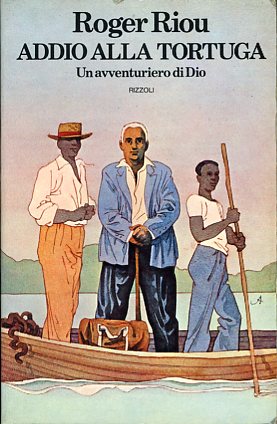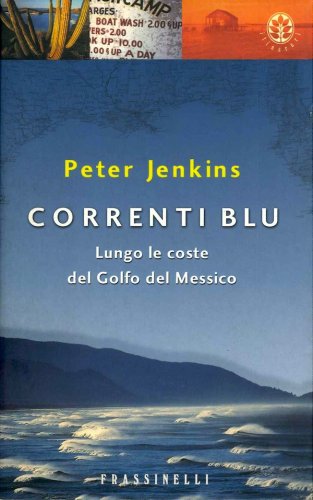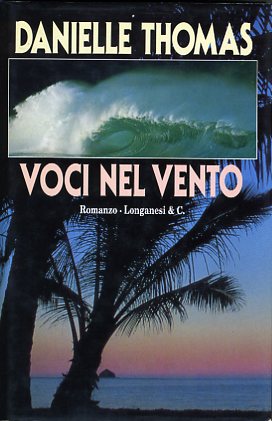Odissea
Odissea
- Disponibile in 7 giorni
- Possibilità di reso entro 10 giorni lavorativi
- Transazione sicura con carta di credito, Paypal o bonifico bancario
- Spedizione tracciata con SDA
Secondo la leggenda, Alessandro Magno, nei suoi viaggi, aveva il rotolo dell’Iliade in un forziere d’oro, trainato da cavalli finemente bardati. Ogni notte, si faceva leggere brani dal poema di Omero: si riteneva l’incarnazione di Achille, la lettura confortava la sua impresa. Penetrando l’Oriente, arrivò in Punjab: una moneta commemorativa, battuta a Babilonia, ferma Alessandro che cavalca Bucefalo, impennato, mentre disarciona, dal suo elefante da guerra, il re indiano Poro, alleato di Dario III. Diversi secoli dopo, a Miranashah, nei recessi pachistani, tra colli crudi e noia, cruenta, un uomo non diverso da Alessandro per indole, devoto alla ribellione, ai gesti che destano ammirazione e polvere, comincia a tradurre l’Odissea. A differenza di Alessandro Magno, però, Thomas Edward Lawrence, che nel 1918 diventò – per un gioco di miraggi ed esotico hollywoodiano – ‘Lawrence d’Arabia’, voleva dissipare la grandezza che si era conquistato. Scartavetrò il suo nome – i suoi nomi: amava la gioielleria degli pseudonimi, T.E. – si affiliò prima alla Royal Tank Corps, poi rientrò nella RAF. Viveva da anonimo, preferì essere spedito nell’anonimato d’Oriente. L’uomo che aveva fatto la Storia, la rifiutava, ne abitava le propaggini oscure, convinto, forse, che il tempo è una iena, la volontà il respiro obliquo di un lebbroso. Amava l’etimo del corpo, Lawrence, il brigantaggio delle identità: per lui, la letteratura non era che rimestare le sabbie, dare adito a un suono, abito a una malinconia d’argento.