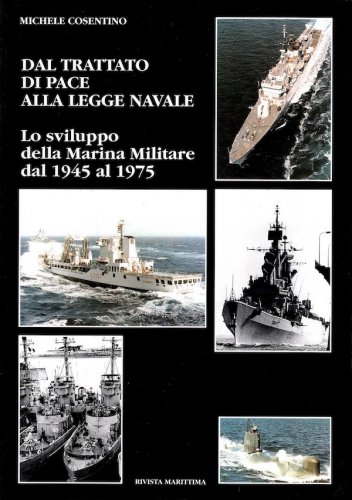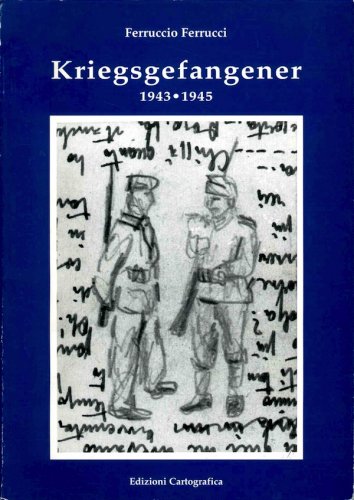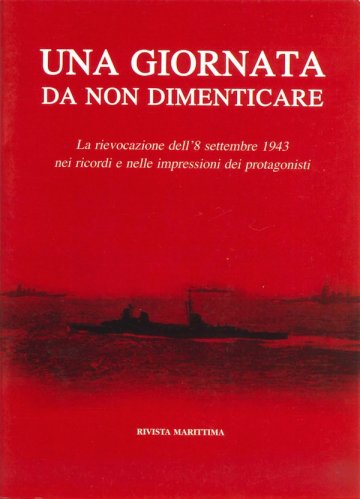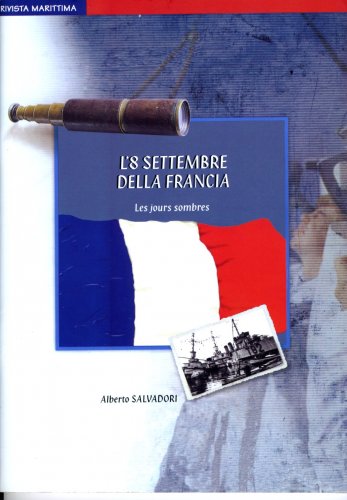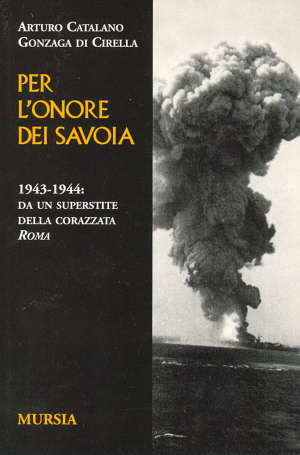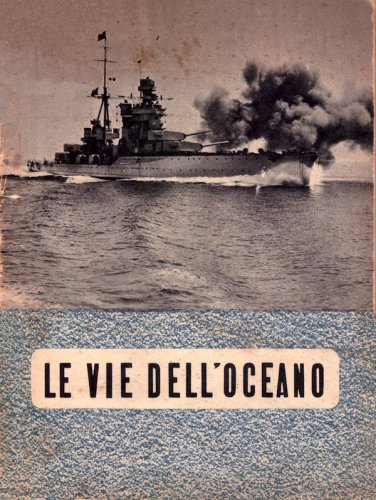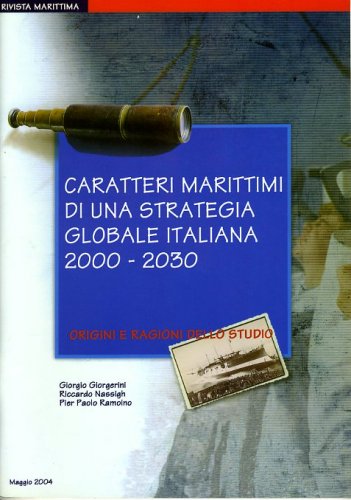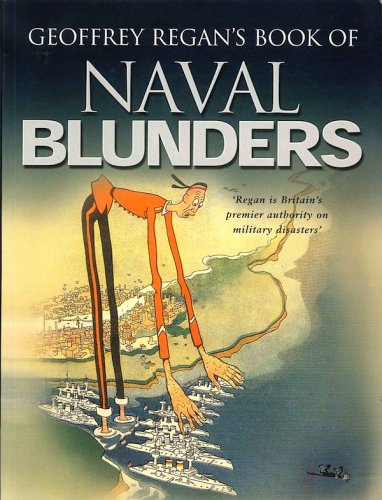Dal trattato di pace alla legge navale
lo sviluppo della Marina Militare dal 1945 al 1975
Dal trattato di pace alla legge navale
lo sviluppo della Marina Militare dal 1945 al 1975
- Disponibile in 7 giorni
- Possibilità di reso entro 10 giorni lavorativi
- Transazione sicura con carta di credito, Paypal o bonifico bancario
- Spedizione tracciata con SDA
Alla fine della seconda guerra mondiale, l'Italia viveva uno dei periodi più tristi della sua storia nazionale. Le condizioni economiche del Paese dipendevano in pratica dalla benevolenza degli Alleati e il territorio era formalmente sotto un regime di occupazione militare; le Forze Armate uscivano pesantemente logorate da un conflitto protrattosi per circa 60 mesi, di cui oltre la metà contro quelle che allora erano le principali Potenze navali del pianeta. Nonostante tale contesto e le dolorose perdite in termini umani e materiali, la Regia Marina rappresentava ancora una delle poche istituzioni capaci di garantire una certa continuità di spiriti e d'intenti. Con uno stato d'animo frustrato dalle prevedibili condizioni che il Trattato di Pace le avrebbe imposto, essa si avviò comunque verso la ricostruzione, che si prospettava oltremodo lunga e faticosa, e l'impostazione di una propria ristrutturazione in funzione delle tangibili esigenze di difesa dell'integrità territoriale del Paese. Le umilianti restrizioni del Trattato di Pace consentirono di avviare solamente un'attività forzatamente limitata all'addestramento del personale e finalizzata alla vigilanza del fronte a mare a ridosso dei confini orientali; questa direttiva di carattere generale si protrasse in sostanza fino ai primi anni Cinquanta, quando l'adesione alla NATO e il progressivo deterioramento della situazione internazionale consentirono, grazie anche al trasferimento di naviglio e sistemi d'arma provenienti d'oltreoceano, di ampliare gli orizzonti della politica navale nazionale e definire concretamente criteri d'impiego delle forze marittime che prevedevano un maggior impegno sul fronte mediterraneo. La rinascita dell'economia nazionale, dovuta anche al grosso impegno profuso dalla Marina per la riattivazione dei porti e delle infrastrutture, permise l'impostazione di un programma navale che, seppur limitato nella consistenza, aveva il suo fondamento nella protezione del territorio nazionale e delle linee di comunicazione marittime facenti capo alla penisola. L'appartenenza all'Alleanza Atlantica e la collaborazione con le Marine alleate operanti in Mediterraneo costituirono il leitmotiv della politica navale italiana degli anni Cinquanta e Sessanta, da cui emersero una ben precisa percezione della minaccia e scelte determinate in materia di nuove costruzioni; i limitati stanziamenti devoluti all'ammodernamento dei mezzi in servizio provocarono però una grave crisi morale e materiale, che toccò la fase più acuta a cavallo del 1970. Le chiare e decise prese di posizione dei vertici della Marina, per la quale si determinò un riconoscimento generale del suo insostituibile ruolo, consentirono di evitare il processo di lenta ma sicura estinzione della flotta italiana. La Legge Navale, che ne derivò, rappresentò un punto di partenza verso lo sviluppo di uno strumento il quale, seppur condizionato da una realtà economica non sempre favorevole, ha saputo svolgere con dignità ed efficacia i suoi compiti istituzionali. E la testimonianza più palese di quanto opportune fossero state le scelte effettuate al tempo della Legge Navale è venuta dalla sempre più crescente e attiva partecipazione della Marina alle vicende militari internazionali. Scopo di queste note è quindi quello di ripercorrere il cammino intrapreso dalla Marina Militare dalla ricostruzione fino alla promulgazione della Legge Navale, per rendere omaggio a quanti vi hanno contribuito e far prendere coscienza del compito che le forze navali italiane sono chiamate a svolgere nel superiore interesse del Paese.